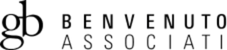Revocabile il sindaco che non vigila sugli assetti della Società
Tribunale di Milano, sez spec in materia d’impresa, decreto del 21 luglio 2024, Giudice est. Dott. Fascilla, Presidente Dott.ssa Simonetti
Massima
È revocabile per giusta causa ai sensi dell’art. 2400 c.c. il sindaco che venga meno agli obblighi di vigilanza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, omettendo di segnalare eventuali criticità che emergano dal regolare scambio di dati e di informazioni rilevanti con gli amministratori e il soggetto incaricato della revisione ovvero dalle ispezioni e i controlli a cui è tenuto l’organo di controllo ai sensi dell’art. 2403 bis c.c..
***
1. L’obbligo di vigilanza dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società
I doveri di controllo imposti ai sindaci sono contraddistinti da particolare ampiezza, estendendosi a tutta l’attività sociale in funzione della tutela dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali: al sindaco è infatti demandata la verifica dell’osservanza della legge e dello statuto, del rispetto dei principi di corretta amministrazione e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2403 cc).
Per consentire un effettivo esercizio dei suddetti obblighi di controllo il sindaco dovrà svolgere una serie di attività informative e valutative ex art. 2403 bis cc senza rimanere in alcun modo “acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell’amministratore quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario avendo il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell’inerzia alle altrui condotte dannose senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all’organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd azioni correttive necessarie” (Cass. n. 18770/2019).
Esercitati i suddetti poteri informativi, riscontrate anomalie o reticenze dell’organo gestorio ad una disclosure chiara e tempestiva, al sindaco sono attribuiti tutta una serie di strumenti di reazione (ben elencati anche in Cass. n. 24045/2021) tra cui possono annoverarsi:
– la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. ove fosse stata omessa dagli amministratori o per la segnalazione all’assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate;
– il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite;
– i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime;
– l’impugnazione delle deliberazioni viziate;
– il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c.;
– la denuncia al tribunale in presenza di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.).
– ed ora anche la domanda di Liquidazione Giudiziale (art 37 ccii)
Tra i poteri di controllo del sindaco può considerarsi l’obbligo di vigilanza dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società imposto dall’art. 2403 c.c. che, come indicato nella massima in commento, in caso di violazione, conferisce all’assemblea il potere di revoca per giusta causa dello stesso oltre che dell’amministratore (Trib. Catania sentenza del 8 febbraio 2023), a cui, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 2409 c.c., può peraltro temporaneamente sostituirsi un amministratore giudiziario nominato dal tribunale affinché predisponga gli adeguati assetti organizzativi (Trib. di Roma, decreto del 10 aprile 2024, rg 12394/2023; Trib Catanzaro, decreto del 06/02/2024 rg. 2034/2023).
La legittimità dell’esercizio del potere di revoca dovrà verificarsi caso per caso e la delibera dovrà essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato (art. 2400 c.c.).
Malgrado l’art. 3, co. 2, ccii preveda che l’imprenditore collettivo debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa ai sensi dell’art. 2086 c.c. né il codice civile né il codice della crisi definiscono cosa si intenda per “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile”; è noto infatti che l’intervento normativo che permea tutta la riforma del diritto della crisi e da cui è scaturito il nuovo codice si basi sull’introduzione di meccanismi di early warnig volti ad incidere sui doveri di natura organizzativa affinché la crisi venga individuata precocemente sin dai primi segnali della stessa.
Pur non potendosi rinvenire nella normativa citata una definizione, utili supporti sono pervenuti da autorevoli fonti quali il CNDCEC che in diversi documenti di ricerca licenziati dallo stesso (ci si riferisce alle pubblicazioni del 20 e 21 dicembre 2023 in tema di comportamento del collegio sindacale; 7 luglio 2023 in tema di profili civilistici e aziendalistici degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; 24 luglio 2023 sempre in tema di assetti con un particolare focus alle check list operative) mutua dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (ultima edizione gennaio 2024), la definizione di cosa si intenda per:
-assetto organizzativo: complesso delle direttive e procedure per stabilire e garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; complesso procedurale di controllo; flussi informativi attendibili ed efficaci tra organi e funzioni aziendali;
-assetto amministrativo-contabile: direttive, procedure e prassi che garantiscano la correttezza, completezza e tempestività di un’informativa societaria attendibile in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa.
Per assetto deve pertanto intendersi ciò che attiene alla divisione del lavoro, all’inquadramento dei ruoli e delle funzioni affinché l’impresa possa pianificare, programmare e gestire il rischio tramite adeguati flussi informativi e sistemi di reazione; un recente sforzo definitorio è stato peraltro condotto dalla Corte d’Appello di Roma con decreto del 27 maggio 2024, rg 50654/2024 che classifica gli assetti amministrativi come “un insieme di procedure, di linee guida precostituite, che siano idonee ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività d’impresa e delle loro singole fasi, in base alle dimensioni, caratteristiche e struttura dell’impresa”.
Chiarito nei termini indicati il significato di “assetti”, rimane da comprendere se l’istituzione degli assetti possa considerarsi un obbligo giuridico e cosa si intenda per adeguatezza.
L’art. 2381, co. 5, c.c. utilizza il verbo “curare” gli assetti e dunque, secondo un orientamento ormai rimasto minoritario, il legislatore avrebbe inteso istituire una facoltà per l’imprenditore e non un obbligo di legge; la giurisprudenza maggioritaria, al contrario, si è espressa in favore dell’obbligatorietà da valutarsi in ragione della natura e delle dimensioni dell’impresa (Tribunale di Catanzaro, sez. spec. imprese sent. del 6/2/2024; Trib. Milano sez spec. sent. n. 11105/2019 pubblicata il 3/12/2019; Trib. Cagliari, sez spec impr., decreto del 19 gennaio 2022; Tribunale di Catania decreto del 8 febbraio 2023).
Il richiamo alla natura e alle dimensioni dell’impresa ci consente di introdurre anche il concetto di adeguatezza, anch’esso francamente non immune ad una certa sfuggevolezza agli occhi del pratico, malgrado il soccorso di uno degli ultimi documenti del CNDCEC, datato 25/7/2023, dal titolo promettente: “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check list operative” che, con il supporto di questionari, guida l’imprenditore in un’autovalutazione circa l’adeguatezza o meno della struttura sulla base del principio di proporzionalità.
Al netto di qualunque autovalutazione, certo non si può mancare di osservare come l’obbligo di adeguatezza soffra di significativi limiti dati dalla discrezionalità e insindacabilità delle scelte gestorie e dunque ben ha ritenuto la Corte d’Appello di Brescia con ordinanza del 12 luglio 2024, rg 407/2023, di rimarcare, sempre in tema di adeguatezza degli assetti, che “la scelta organizzativa rimane pur sempre discrezionale ed insindacabile e il limite è costituito dal fatto che il criterio di condotta, a cui gli amministratori devono attenersi, è quello generale dell’adeguatezza e ragionevolezza”.
A conclusione di questo primo paragrafo deve infine darsi evidenza di uno degli aspetti centrali, e per alcuni versi innovativi, che sta emergendo dalla recente giurisprudenza di merito: l’obbligo di adozione degli adeguati assetti organizzativi non può circoscriversi ai casi in cui l’impresa si trovi in uno stato di crisi conclamata ma al contrario la mancata adozione di adeguati assetti è stata considerata ancor più grave in una situazione di equilibrio economico finanziario in quanto trattasi di una condizione in cui la società dispone delle necessarie risorse per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative adottando gli adeguati assetti e si trova in una posizione favorevole in ottica di evitare che l’impresa, inconsapevolmente, scivoli in una situazione di crisi, consentendo al contrario all’organo amministrativo di attivarsi tempestivamente assumendo le opportune iniziative (Trib. Cagliari, sez spec impr., decreto del 19 gennaio 2022 peraltro condivisa anche da Trib. di Catanzaro, sez spec impr, decreto del 6 febbraio 2024).
2. Il doppio binario della revoca e dell’azione risarcitoria: i confini della revoca del sindaco per giusta causa
Accertata la portata degli obblighi di istituire adeguati assetti e -lato sindaci- di vigilare costantemente sul loro funzionamento, qualche breve riflessione meritano gli aspetti processuali dell’approvazione della deliberazione di revoca, di natura non contenziosa e caratterizzata da chiari limiti ai poteri d’indagine del tribunale che dovrà valutare, senza che la parte ricorrente possa introdurre nuovi temi, i seguenti elementi:
i) il rispetto del contradditorio, in quanto il sindaco deve essere stato messo nella condizione di comprendere le contestazioni mediante rituale convocazione avanti all’assemblea;
ii) la non genericità delle contestazioni sollevate, che dovranno in ogni caso essere indicate nella delibera di approvazione della revoca;
iii) la riferibilità delle circostanze a contestazioni che possano essere ricondotte o alla violazione delle obbligazioni previste dalla legge a carico dei sindaci o comunque a fatti circostanziati che possano aver messo in pericolo il rapporto fiduciario tra amministratori e sindaci;
iv) la non pretestuosità delle contestazioni in modo da evitare “strategici” allontanamenti di sindaci non graditi.
Al netto dei poteri di indagine sopra elencati, in sede di approvazione della delibera di revoca ex art. 2400 c.c., il giudicante non potrà entrare nel merito delle contestazioni sollevate in quanto il provvedimento di approvazione: “non comporta in alcun caso il riconoscimento, nemmeno implicito, della responsabilità del sindaco revocato” (passaggio presente nel decreto in commento) che pertanto dovrà essere oggetto di separata domanda giudiziale.
Il sindaco, infatti, non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso in ragione della sua mera posizione di garanzia perché investito di una responsabilità concorrente rispetto a quella degli amministratori che trova fondamento nell’art. 2407, co. 2, cc che scaturisce dalla violazione degli obblighi di vigilanza sull’operato degli amministratori (con particolar riferimento alla vigilanza sull’obbligo in capo agli amministratori, di adottare le misure necessarie a preservare l’integrità del patrimonio sociale a garanzia delle ragioni dei creditori), nonché dalla violazione degli obblighi di attivazione e intervento previsti ex lege dopo aver riscontrato il comportamento illecito degli amministratori (Corte d’Appello di Napoli, sez I, sent. n. 3020 del 2 luglio 2024).
Il sindaco risponderà pertanto del mancato esercizio di specifici poteri/doveri di cui è investito ai fini del concreto ed efficace esercizio della sua funzione di vigilanza: tale responsabilità è una fattispecie complessa che richiede la congiunta presenza di un fatto o omissione degli amministratori, di un’omessa vigilanza in capo ai sindaci e di un nesso di causalità tra condotta dei sindaci e danno subito.
In definitiva, la responsabilità dei sindaci, pur trovando la sua fonte in un comportamento altrui (ossia quella degli amministratori), si sostanzia comunque in una violazione di dovere proprio e dunque non può essere configurato alcun automatismo tra condotta dell’amministratore e responsabilità dei sindaci.
Se è dunque vero che il sindaco non risponde in modo automatico di ogni fatto dannoso aziendale si esige tuttavia, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l’intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge ed infatti “in tema di azioni di responsabilità verso l’organo sindacale, l’onere di allegazione e di prova si atteggia nel senso che spetta all’attore allegare l’inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull’avviso; assolto tale onere, l’inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l’onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale” (Cass. n. 2350/2024).
Ad escludere l’inadempimento dei sindaci non è peraltro sufficiente l’avere assunto la carica dopo che si sono realizzati alcuni dei fatti dannosi ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
Nello stesso modo in cui le dimissioni presentate, ove non fossero accompagnate anche da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti gestori, non escludono l’inadempimento del sindaco posto che, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato, la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo e le dimissioni rappresentano, anzi, circostanze esemplari della sua condotta colposa, rimasto indifferente ed inerte di fronte ad una situazione di illegalità (Cass sez I ordinanza del 9/04/2024 n. 9427).
Un ultimo accenno meritano infine le novità introdotte dal correttivo al codice della crisi di recente approvazione, d. lgs n 136/2024, che ha sancito l’attenuazione o l’esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 ove l’organo di controllo segnali tempestivamente (entro 60 giorni dalla conoscenza) la sussistenza di situazioni di crisi o insolvenza di cui all’art. 2, co. 1, lett a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 ccii, mentre sono ancora in discussione le modifiche all’art. 2407, co. 2, cc volte a limitare quantitativamente la condanna risarcitoria in proporzione ai compensi percepiti, ad esclusione dei casi in cui vengano accertate condotte dolose.
Chiariti pertanto i contorni della responsabilità del sindaco in caso di violazione dei doveri derivanti dall’incarico, risulta quasi sempre complicato in tema di inadeguata o mancata predisposizione di assetti orientare l’operatore tra i vari strumenti proposti dall’ordinamento.
Ove infatti la società si dovesse trovare ancora in bonis, come sopra visto, lo strumento più efficace di reazione a cui potrà accedere il sindaco è, con tutta probabilità, la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e la conseguente nomina di un amministratore giudiziario.
Non sempre tuttavia tali iniziative vengono assunte tempestivamente proprio per la frattura che tale strumento rivela nei rapporti tra organi sociali e ci si chiede allora se dalla violazione degli obblighi di vigilanza sulla predisposizione di adeguati assetti possano scaturire anche domande risarcitorie ai sensi dell’art. 2407 c.c.
Le pronunce sino ad oggi intervenute non registrano l’accoglimento di tali domande[1], preferendo piuttosto concentrarsi sulle conseguenze incontrate dalla società per l’omessa liquidazione a seguito della perdita di capitale o per il mancato tempestivo accesso agli strumenti di reazione previsti dal codice della crisi (composizione, concordato etc).
Tale dato ci induce a ritenere che i tempi non siano ancora maturi a ricollegare all’inadempimento degli obblighi di istituire adeguati assetti una fonte di risarcimento anche in quanto il sistema di piccole-medie imprese a conduzione familiare in cui sono andate ad innestarsi le ultime riforme in materia, gioca ancora un ruolo decisivo negli standard organizzativi e amministrativi.
Un paio di considerazioni conclusive tuttavia paiono d’obbligo.
Non si esclude che presto potrebbero trovare accoglimento domande risarcitorie nei confronti di amministratori e sindaci di società totalmente prive di assetti o a tal punto inadeguati (si pensi ad assetti che non siano in grado di arginare la commissione di reati tributari) da rasentare l’assenza; maggiori difficoltà si intravedono nell’argomentare domande risarcitorie derivanti dall’inadeguatezza degli assetti che hanno quale ineludibile presupposto il superamento dei limiti della discrezionalità delle scelte gestorie (cd business judgement rule che limita il sindacato del giudice a scelte irragionevoli e manifestatamente imprudenti) e arrivare a dimostrare in giudizio la sussistenza di una rapporto causale tra il danno al patrimonio sociale e l’inadeguatezza degli stessi.
In ogni caso, formulata la domanda risarcitoria, spetterà agli organi sociali la prova della istituzione e del funzionamento degli adeguati assetti – prova indubbiamente più agevole se gli stessi possono contare su procedure e regolamenti in precedenza redatti per iscritto – e di aver svolto un costante monitoraggio dell’andamento dell’impresa.
La materia è in evoluzione e ancora avvolta da aree di incertezza; tuttavia è chiaro che quando si affrontano giudizi risarcitori non è sufficiente indicare la violazione di obblighi di legge ma si rende necessario completare la presentazione dei requisiti dell’azione attraverso l’indicazione di un danno al patrimonio e di un nesso causale che lega questo alla violazione, restando, in difetto, disattesa l’aspettativa di successo dell’azione; ciò spiega la ragione per cui la tematica della violazione degli adeguati assetti è stata prevalentemente impiegata in giudizi che l’hanno affrontata nel perimetro delle denunce delle gravi irregolarità di corretta amministrazione e assai meno in giudizi avviati per reclamare il risarcimento del danno al patrimonio la cui riconduzione alla mancanza di adeguati assetti è risultato – ad oggi – complicato.
[1] Circostanza peraltro confermata anche dal Presidente della Sezione Imprese del Tribunale di Milano in occasione del convegno del 14 dicembre 2023 come riportato in “L’imprenditore e l’art. 2086, secondo comma, c.c.: un nuovo dovere che chiede pieno riconoscimento”, in NT+diritto, inserto de Il Sole 24 ore a cura dell’avv. Alessandro Palma